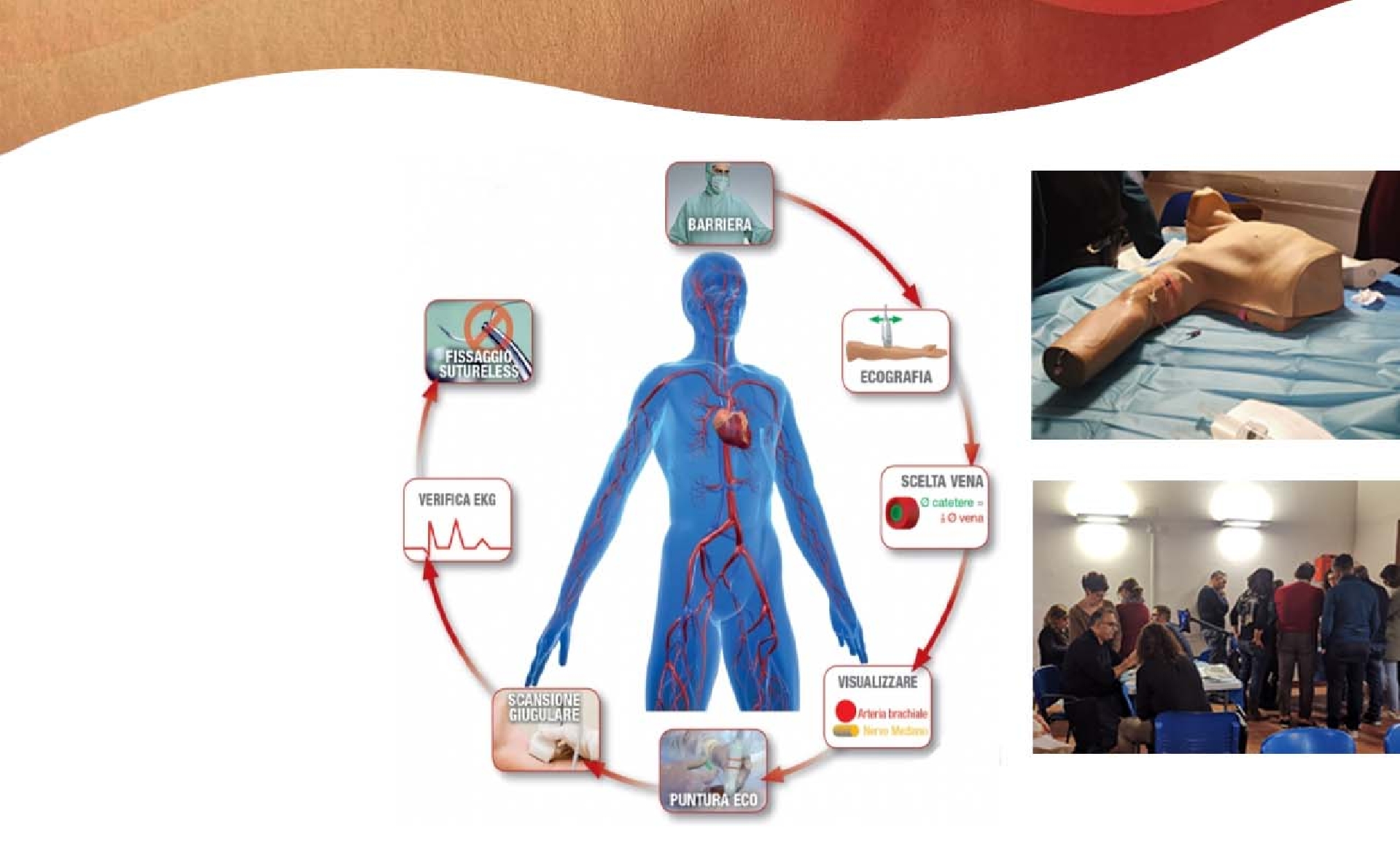La Medicina difensiva
Bisognerebbe, con molta umiltà, recuperare il concetto del “to care” (avere cura) a scapito del “to cure” (curare)
Se la medicina attrae critiche, i medici attirano denunzie ed esposti. È una triste realtà quella delle statistiche che mostrano il numero di cause penali e civili intentante contro, presunti, errori medici. Le stesse statistiche ci dicono poi che più dell’ottanta per cento di tali cause si risolvono con il non luogo a procedere o con l’assoluzione piena e totale dei medici interessati. L’esperienza mediatica e giudiziaria a cui viene sottoposto un medico è certamente devastante. Il medico riceve un avviso di garanzia. Sicuramente a propria “garanzia”, bastevole a farne spesso comparire il nome sulla stampa. La difesa consiste fondamentalmente in due azioni: la prima consiste nel provvedere a stipulare polizze assicurative, peraltro sempre più care e, a volte, dai costi insostenibili per le branche più a rischio quali la ginecologia, l’ortopedia e in genere le specialità chirurgiche. Ancorché si trovi una compagnia assicurativa disposta a stipularle.
La seconda azione è rappresentata dalla ‘fuga’ da alcune branche della medicina. Negli Stati uniti si sta concretizzando un esempio di fuga, messo in atto dai medici ginecologi che oramai si dedicano esclusivamente alla ginecologia non volendo, o non potendo, occuparsi della ostetricia. Il parto è un evento naturale gravato da ineliminabili rischi sia per il bambino sia per la madre. Vi è però connaturata alla seconda azione anche la fuga dal ragionamento clinico, dalle “evidenze” diagnostiche e terapeutiche, in breve la fuga dal “prendersi cura del paziente”.
Gradualmente ci si concentra esclusivamente nell’adottare comportamenti professionali che non possano dare adito a eventuali azioni risarcitorie, subissando il paziente di inutili indagini diagnostiche, che comportano stress ai pazienti e sperpero economico per le già esigue risorse della sanità. Non si pensa al paziente, bensì al magistrato potenzialmente chiamato a giudicare il nostro operato. Ed è naturale che se un paziente è danneggiato è palese che abbia diritto a un sacrosanto risarcimento.
Il problema dell’errore in medicina è argomento complesso. Bisogna considerare, per esempio, che nella maggior parte dei casi laddove sia riconosciuto un “errore” esso più che al comportamento del singolo medico è riconducibile alle carenze strutturali e alle pecche dell’organizzazione interna del sistema nel quale il medico è chiamato a operare.
La criminalizzazione del singolo, con la pubblica gogna, con il “crucifige” e, soprattutto, basata sulla base di motivazioni economiche non aiuta certo a risolvere il problema.
Il principio del “consenso informato”, enunciato per la prima volta nel 1914 nel caso Schloendorff vs New York Hospital dal giudice B. Cardozo, si diffonde con i casi Salgo vs Leland Standford Jr. University, Board of Trustees del 1957 e Natason vs Kline del 1960, tutte, appunto, cause risarcitorie. La sentenza del 1914 recita: “Il trattamento chirurgico e anche quello medico rappresentano in se stessi, se non preceduti dal consenso, una invasione del corpo di una persona che produce obbligo di risarcimento”. Il problema della “medicina difensiva” si pone come problema “culturale”, e solo con una “rivoluzione culturale” può, e deve, essere risolto. La riflessione sulle “origini” della professione medica può aiutarci però a vedere alcuni aspetti complessi del fenomeno. Nel “giuramento” medico sono citati Apollo, Esculapio, Igea e Panacea. Nella tradizione Igea valorizza la natura, il corpo che va rispettato e tutelato, insomma la prevenzione o, meglio, “l’aver cura”. L’altro “ramo” è rappresentato da Esculapio e Panacea (la guaritrice di tutti i mali) che cercano di correggere la natura, ponendo rimedio con interventi esterni e aggressivi: il “curare”.
Verosimilmente nel corso degli anni, e infervorati degli indubbi successi ottenuti dalla medicina moderna, il rapporto equilibrato tra i due “rami” si è sbilanciato a favore del secondo, cioè dell’intervento armato per correggere la natura”. La medicina si è sempre più tecnologizzata” e via via si è diffusa la convinzione (o meglio l’illusione) non solo di poter combattere la malattia e la morte, ma addirittura di dominarle e, in un futuro più o meno prossimo, di sconfiggerle.
Si è passati da una medicina dei “bisogni” di salute a una medicina dei “desideri”. Non solo la sofferenza, ma anche i disagi ed i fastidi devono trovare adeguata risposta. Risposta che deve essere moderna e tecnologica e, quindi, farmaci ed esami diagnostici.
Si pensi alla estrema “medicalizzazione” di eventi assolutamente naturali, come la gravidanza, al ricorso sempre maggiore a procedure “estetiche”, all’uso voluttuario di farmaci (si stima che i due terzi dei farmaci per il deficiterettile siano adoperati non da soggetti con tale patologia, ma per aumentare le prestazioni di soggetti assolutamente sani).
Si sono trasferite malattia e morte dalla propria sfera biologica alla dimensione tecnologica. Viviamo, insomma, in un’era che può definirsi di “neopositivismo medico”.
Insistendo sulla possibilità di un continuo miglioramento (migliore salute, vita più lunga, riduzione delle menomazioni) s’innesca quel meccanismo perverso che genera la pericolosa spaccatura tra ciò che le persone sperano e ciò che realmente possano ottenere. Da qui il paradosso della nostra epoca: “stare meglio, ma sentirsi peggio”.
Si aggiungano, in ultimo, gli influssi sempre più pressanti esercitati sulla medicina dal “mercato”. Sicuramente “la salute non ha prezzo”, ma altrettanto sicuramente “ha un costo”. D’altronde non si può dimenticare che la medicina avendo come obiettivo centrale il malato, mantiene il carattere fondamentalmente filantropico, mentre il “mercato”, secondo una delle definizioni possibili, è un “meccanismo di scambio che pone in relazione venditori e acquirenti di un prodotto, di un mezzo di produzione o della sicurezza finanziaria”. Nel contesto attuale ci troviamo in una condizione estremamente complessa e difficile, segnata dalla progressiva “disumanizzazione” della medicina moderna.
Bisognerebbe, con molta umiltà, recuperare il concetto del “to care” (avere cura) a scapito del “to cure” (curare), valorizzando, sia medici che pazienti, quei valori culturali di ossessione meno marcata per il progresso medico e per l’innovazione tecnologica, minore intransigenza nel perfezionismo e nell’avversione al rischio, serena accettazione della morte e minore accanimento nei confronti dei difetti della natura umana, maggiore disponibilità ad accettare un certo grado di dolore e sofferenza come normali senza farne sempre e comunque bersaglio della medicina.
Giovanni Merlino